- Buddhismo
 Il
Buddhismo è una religione nata in India sulla base degli insegnamenti
di Siddhartha Gautama, detto il Buddha ("l'Illuminato, il Risvegliato").
Egli allevato nel lusso e nell'agiatezza in quanto figlio di un piccolo
re locale, rimase profondamente scosso dalla scoperta dell'infinito dolore
che incombe su tutti gli esseri umani, costretti da una forza ineluttabile
a vivere esistenze sempre nuove nel ciclo inarrestabile della reincarnazione.
Siddhartha decise, all'età di ventinove anni, di lasciare la reggia
paterna per dedicarsi, libero dall'attaccamento ai beni materiali, alla
ricerca di una via che conducesse alla liberazione dalla sofferenza e
alla felicità suprema. Si dedicò dapprima allo yoga e alle
pratiche di un ascetismo, adottò quindi una via media fra la vita
agiata e la mortificazione assoluta, per approdare poi, nell'ultima fase
del suo cammino, alla definitiva illuminazione.
Il
Buddhismo è una religione nata in India sulla base degli insegnamenti
di Siddhartha Gautama, detto il Buddha ("l'Illuminato, il Risvegliato").
Egli allevato nel lusso e nell'agiatezza in quanto figlio di un piccolo
re locale, rimase profondamente scosso dalla scoperta dell'infinito dolore
che incombe su tutti gli esseri umani, costretti da una forza ineluttabile
a vivere esistenze sempre nuove nel ciclo inarrestabile della reincarnazione.
Siddhartha decise, all'età di ventinove anni, di lasciare la reggia
paterna per dedicarsi, libero dall'attaccamento ai beni materiali, alla
ricerca di una via che conducesse alla liberazione dalla sofferenza e
alla felicità suprema. Si dedicò dapprima allo yoga e alle
pratiche di un ascetismo, adottò quindi una via media fra la vita
agiata e la mortificazione assoluta, per approdare poi, nell'ultima fase
del suo cammino, alla definitiva illuminazione.
Da allora Siddhartha, divenuto finalmente il Buddha, "l'illuminato", si impegnerà instancabilmente nella sua opera di predicazione della sua dottrina delle Quattro nobili verità. La vita è sofferenza: il dolore (dukkha) e l'inconsistenza costituiscono l'essenza più profonda della vita umana dalla nascita alla morte così che quest’iltima non rappresenta in alcun modo la liberazione dal dolore, in quanto, conformemente alla concezione fondamentale del pensiero indiano, l'uomo è soggetto, come tutti gli esseri, al flusso inarrestabile delle rinascite, reincarnandosi continuamente in corpi sempre diversi.
Origine
di tutto questo carico di sofferenza è l'ignoranza della natura
illusoria di tutto ciò che l'uomo percepisce come suo orizzonte
reale: da questa ignoranza non scaturisce solo la schiavitù dei
beni materiali, ma anche, come frutto del desiderio di sopravvivenza,
l'attaccamento alla vita stessa. Alla sofferenza si può porre fine
soltanto mediante l'eliminazione del desiderio e l'estinzione di ogni
forma di attaccamento all'esistenza, al fine di spezzare definitivamente
la catena delle rinascite. Per ottenere la liberazione dal dolore occorre
camminare sulla via dell'Ottuplice sentiero, che racchiude in sé
retta visione, retta intenzione, retto parlare, retto agire, retto modo
di sostentarsi, retto impegno, retta consapevolezza, retta meditazione:
si tratta, in pratica, del compendio fondamentale della fede buddhista,
che vede nella moralità la premessa e insieme la conseguenza della
saggezza e della capacità di possederla attraverso la meditazione.
 Di
conseguenza, l'individuo è indotto alla ricerca spasmodica di una
sorta d'immortalità attraverso la rinascita continua in corpi materiali
sempre nuovi: ogni esistenza è così legata indissolubilmente
alle infinite esistenze precedenti e a quelle future, in una catena inestricabile
di sofferenza che il saggio deve necessariamente spezzare.
Di
conseguenza, l'individuo è indotto alla ricerca spasmodica di una
sorta d'immortalità attraverso la rinascita continua in corpi materiali
sempre nuovi: ogni esistenza è così legata indissolubilmente
alle infinite esistenze precedenti e a quelle future, in una catena inestricabile
di sofferenza che il saggio deve necessariamente spezzare.
In questo indirizzo di pensiero trova posto anche l'altro concetto portante
della tradizione indiana, quello di karma, la conseguenza etica indotta
dal complesso delle azioni che l'individuo compie in ciascuna esistenza,
determinando inesorabilmente la sua condizione nell'esistenza successiva,
secondo una logica di premio e di punizione: la condotta in vita porta
con sé la possibilità di rinascere sotto forma di animale,
oppure di uomo, di demone, di divinità.
Il fine ultimo dell'uomo che segue il cammino di salvezza suggeritogli
dal Buddha è il raggiungimento della condizione suprema del nirvana,
l'estinzione di ogni desiderio e la libertà da ogni forma di condizionamento
materiale e psicologico: ottenuta questa illuminazione interiore, il saggio
prosegue il cammino della sua esistenza terrena liberandosi gradualmente
del carico del karma che lo lega al corpo materiale e preparando la strada
alla liberazione definitiva, la condizione del parinirvana, il nirvana
definitivo, l'annientamento totale che coincide con il momento della morte.
Raggiungibile teoricamente da tutti i fedeli, questa condizione di beatitudine
eterna è posta più realisticamente come meta principale
soltanto per i membri della comunità monastica. Questi ultimi devono
mirare a ottenere l'illuminazione e a essere venerati come arhat, saggi
giunti allo stato di perfezione al termine del lungo cammino sulla via
dell'Ottuplice sentiero. Agli altri fedeli non resta che rassegnarsi all'accumulo
di meriti che consente, attraverso l'osservanza, nel corso della lunga
vicenda delle rinascite successive, della legge morale – non uccidere,
non rubare, non pronunciare menzogna, non fare uso di sostanze inebrianti
e non abbandonarsi al disordine sessuale – di reincarnarsi finalmente
nella condizione di monaco per compiere il passo decisivo verso la liberazione.
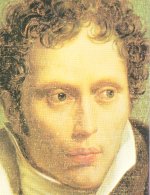 Nella
filosofia di Schopenhauer occupò un posto di rilievo la sapienza
dell’antico Oriente, al quale egli fu avviato da Frederich Mayer.
Il suo rapporto con la tradizione filosofico-religiosa dell’India
è stato variamente interpretato e dibattuto e costituisce uno dei
problemi più complessi relativi al filosofo. È in ogni caso
fuor di dubbio che Schopenhauer sia stato il primo filosofo occidentale
a tentare il recupero di alcuni dei motivi dell’estremo oriente,
dai quali ha ricavato una serie al quanto affascinante d’immagini
ed espressioni di cui ha fatto grande uso nella creazione del suo pensiero.
È stato in oltre un grande ammiratore della sapienza orientale
tanto da sostenere che essa, che con gran facilità stava entrando
nel pensiero occidentale, non potesse essere invece toccata dalle nostre
religioni e conoscenze.
Nella
filosofia di Schopenhauer occupò un posto di rilievo la sapienza
dell’antico Oriente, al quale egli fu avviato da Frederich Mayer.
Il suo rapporto con la tradizione filosofico-religiosa dell’India
è stato variamente interpretato e dibattuto e costituisce uno dei
problemi più complessi relativi al filosofo. È in ogni caso
fuor di dubbio che Schopenhauer sia stato il primo filosofo occidentale
a tentare il recupero di alcuni dei motivi dell’estremo oriente,
dai quali ha ricavato una serie al quanto affascinante d’immagini
ed espressioni di cui ha fatto grande uso nella creazione del suo pensiero.
È stato in oltre un grande ammiratore della sapienza orientale
tanto da sostenere che essa, che con gran facilità stava entrando
nel pensiero occidentale, non potesse essere invece toccata dalle nostre
religioni e conoscenze.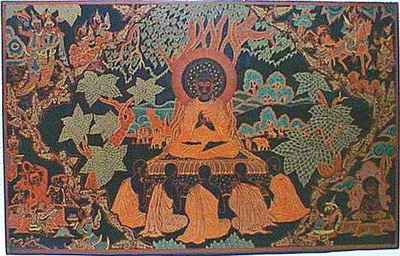 Ed
è proprio dalla filosofia orientale, più precisamente dalla
religione buddista, che Schopenhauer prende spunto per dare il via alla
sua filosofia. Schopenhauer parte infatti dalla distinzione kantiana tra
noumeno e fenomeno, ispirandosi alla filosofia indiana (ben diversa dallo
spirito gnoseologico-scientifico del kantismo. Egli afferma che il fenomeno
non è l’unica realtà accessibile alla mente umana,
ma bensì parvenza, illusione, sogno, ovvero ciò che nell’antica
sapienza indiana è detto “velo di Maya”. Esso esiste
solo dentro la coscienza ("il mondo è la mia rappresentazione)
proprio per questo la vita è "sogno". Mentre il noumeno
non è il concetto-limite della conoscenza, ma è l'essenza
delle cose che si nasconde dietro all'ingannevolezza del fenomeno, e il
filosofo ha compito di scoprirla.
Ed
è proprio dalla filosofia orientale, più precisamente dalla
religione buddista, che Schopenhauer prende spunto per dare il via alla
sua filosofia. Schopenhauer parte infatti dalla distinzione kantiana tra
noumeno e fenomeno, ispirandosi alla filosofia indiana (ben diversa dallo
spirito gnoseologico-scientifico del kantismo. Egli afferma che il fenomeno
non è l’unica realtà accessibile alla mente umana,
ma bensì parvenza, illusione, sogno, ovvero ciò che nell’antica
sapienza indiana è detto “velo di Maya”. Esso esiste
solo dentro la coscienza ("il mondo è la mia rappresentazione)
proprio per questo la vita è "sogno". Mentre il noumeno
non è il concetto-limite della conoscenza, ma è l'essenza
delle cose che si nasconde dietro all'ingannevolezza del fenomeno, e il
filosofo ha compito di scoprirla. 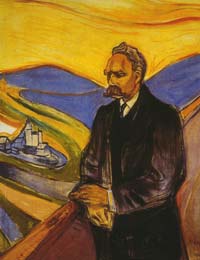 Anche
Nietzsche nella formulazione della sua filosofia subì l’influenza
della religione orientale. Questo è particolarmente evidente quando
il filosofo ci presenta la teoria dell’eterno ritorno dell’Uguale,
ovvero della ripetizione eterna di tutte le vicende del mondo, che riprende
dalle teorie della religione buddista.
Anche
Nietzsche nella formulazione della sua filosofia subì l’influenza
della religione orientale. Questo è particolarmente evidente quando
il filosofo ci presenta la teoria dell’eterno ritorno dell’Uguale,
ovvero della ripetizione eterna di tutte le vicende del mondo, che riprende
dalle teorie della religione buddista.