“…leggo presso molti scrittori che nella lingua dei Persiani il mago equivale al nostro sacerdote…” “avete
sentito, dunque, voi che accusate sconsideratamente la magia, che
essa è un arte accetta agli dei mortali, che ben conosce
il modo di onorarli e venerarli, un arte pia, evidentemente, tanto
è vero che è insegnata tra le prime discipline che
si addicono ad un re, e ad un persiano qualunque non è concesso
di essere un mago, tanto più che essere un re.” |
· I culti misterici a Roma
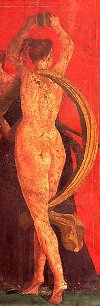 Uno
dei principali filoni culturali del medio-platonismo fu il neo-pitagorismo.
In questo periodo nel tentativo di leggere Platone alla luce di Pitagora
i neopitagorici non compiono un'opera di esegesi storica, bensì
inseriscono nelle loro riflessioni elementi che provengono da tradizioni
culturali molto diverse, e in primo luogo dalle culture orientali: sono
così riprese ideologie religiose e mistiche, credenze popolari
sul mondo ultraterreno, con tutto il corredo di soteriologie, demonologie,
sentenze oracolari, divinazioni; viene accentuata nel contempo quella
tendenza fortemente presente nell'età ellenistica di intendere
la filosofia come "medicina dell'anima" e, di più, come
"salvezza dell'anima".
Uno
dei principali filoni culturali del medio-platonismo fu il neo-pitagorismo.
In questo periodo nel tentativo di leggere Platone alla luce di Pitagora
i neopitagorici non compiono un'opera di esegesi storica, bensì
inseriscono nelle loro riflessioni elementi che provengono da tradizioni
culturali molto diverse, e in primo luogo dalle culture orientali: sono
così riprese ideologie religiose e mistiche, credenze popolari
sul mondo ultraterreno, con tutto il corredo di soteriologie, demonologie,
sentenze oracolari, divinazioni; viene accentuata nel contempo quella
tendenza fortemente presente nell'età ellenistica di intendere
la filosofia come "medicina dell'anima" e, di più, come
"salvezza dell'anima".
S’intendeva
ora la "filosofia" in tutt'altra maniera, più come una
generica "sapienza" capace di assicurare a chi la possiede gli
strumenti per un’elevazione spirituale o addirittura di una salvezza
oltremondana, che come una tecnica di ricerca speculativa o un insieme
di dottrine diverse caratterizzate in ogni modo da un analogo metodo d'indagine.
È indicativo, da questo punto di vista, che l'idea di una derivazione
della filosofia greca dalla sapienza orientale comincia a nascere e ad
affermarsi proprio in questo periodo: i più grandi filosofi greci,
e in primo luogo Platone, non hanno fatto altro che attingere alle sapienze
nascoste della cultura orientale ed agli insegnamenti segreti dei loro
sacerdoti, in primo luogo egiziani ed ebraici.
Il punto d'incontro degli interessi più vivi in questo periodo
è ad Oriente, in Egitto, ad Alessandria. Ad Alessandria  s’insegna
e si pratica la nuova filosofia, quella che soddisfa le esigenze più
sentite del momento: ma proprio mentre la "filosofia" diventa
qualcosa di riservato a pochi iniziati capaci di intraprendere il nuovo
cammino, essa acquista allo stesso tempo i caratteri propri di una nuova
religione "popolare", quegli stessi caratteri dai quali alle
sue origini si era dovuta liberare per costituirsi appunto come filosofia.
s’insegna
e si pratica la nuova filosofia, quella che soddisfa le esigenze più
sentite del momento: ma proprio mentre la "filosofia" diventa
qualcosa di riservato a pochi iniziati capaci di intraprendere il nuovo
cammino, essa acquista allo stesso tempo i caratteri propri di una nuova
religione "popolare", quegli stessi caratteri dai quali alle
sue origini si era dovuta liberare per costituirsi appunto come filosofia.
Le religioni misteriche dell'Oriente con i loro culti, i vecchi riti orfico-pitagorici,
le pratiche magiche, astrologiche e divinatorie, tendevano ormai a soppiantare
le religioni tradizionali, assorbendo per di più dalle filosofie
ellenistiche tutti quegli elementi che valorizzavano e sottolineavano
l'individualità. Come le filosofie ellenistiche puntavano alla
"felicità" del singolo, prescindendo dalla considerazione
del contesto politico nel quale l'individuo viveva ed agiva, così
le religioni misteriche offrivano al suddito dell'impero romano le stesse
"consolazioni": una volta superata l'iniziazione ai culti, qualunque
fosse la gerarchia nella quale il suddito era inserito, il fedele faceva
parte di una comunità d’eletti che gli offriva la certezza
di un contatto diretto e immediato con la divinità e gli garantiva
la salvezza della propria anima, in un mondo nel quale il resto degli
uomini era destinato a perdersi. Questa atmosfera spirituale, che fu alla
base dello stesso cristianesimo, era dovuta anche alla perdita di significato
dei valori filosofici e culturali in genere della Grecia classica, in
un periodo di precarietà e d’incertezza sempre più
diffuse nell'impero di Roma: a partire proprio dalla II metà del
II secolo d.C. il principato non si presentava più dotato di quella
capacità di assicurare pax e tranquillitas che aveva avuto alle
sue origini, e i primi segni di una grave crisi prima economica e poi
politica e sociale cominciano ad apparire all'orizzonte.
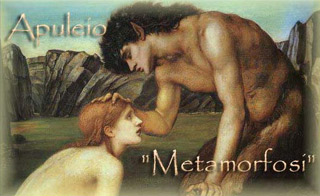 In
questa stessa atmosfera d’accoglimento dei culti misterici orientali
e d’accentuazione degli elementi mistici in una cornice platonica,
si colloca l'opera di Apuleio di Madaura (125 d.C.-?).: Le notizie in
suo riguardo sono poche. Sappiamo che nacque a Madaura intorno al 125
d.C. che è la persona più famosa e affascinante dell’età
degli Antonini, e che studiò a Cartagine, dove apprese le regole
dell’eloquenza latina; si recò poi ad Atene, per avviarsi
allo studio del pensiero Greco. Fu famoso al suo tempo perché si
fece iniziare a tutti i culti più o meno segreti che a quei tempi
abbondavano nell’Oriente mediterraneo. La sua speranza era di trovare
il segreto delle cose e, al pari della sua eroina Psiche, si abbandonava
a tutti i dèmoni della curiosità, avventurandosi fino alle
frontiere del sacrilegio. La strada del ritorno dalla Grecia all’Africa,
lo condusse in Egitto ad Oea (odierna Tripoli), dove incontrò Scizio
Ponziano, un antico compagno di studi di Atene, che lo convinse a sposare
sua madre, Pudentilla, la quale, rimasta vedova, desiderava riprendere
marito. Si sposarono e i parenti della donna, adirati nel vedere compromessa
l’eredità, portarono in giudizio il filosofo accusandolo
di aver plagiato e sedotto la donna con arti magiche per impossessarsi
dei suoi averi, e lo accusarono al governatore della provincia (una legge
dell’81 a.C. prevedeva infatti la pena di morte per chi praticasse
la magia). Per difendersi compose un’arringa scintillante di spirito
che ci è conservata con il titolo di “Apologia”. Dopo
il processo, lo scrittore tornò a Cartagine, dove ottenne varie
dignità e dove proseguì la sua brillante carriera di conferenziere.
Infine, la sua morte va collocata probabilmente dopo il 170 d.C. dal momento
che da quest’anno in poi non abbiamo più notizie sul suo
conto.
In
questa stessa atmosfera d’accoglimento dei culti misterici orientali
e d’accentuazione degli elementi mistici in una cornice platonica,
si colloca l'opera di Apuleio di Madaura (125 d.C.-?).: Le notizie in
suo riguardo sono poche. Sappiamo che nacque a Madaura intorno al 125
d.C. che è la persona più famosa e affascinante dell’età
degli Antonini, e che studiò a Cartagine, dove apprese le regole
dell’eloquenza latina; si recò poi ad Atene, per avviarsi
allo studio del pensiero Greco. Fu famoso al suo tempo perché si
fece iniziare a tutti i culti più o meno segreti che a quei tempi
abbondavano nell’Oriente mediterraneo. La sua speranza era di trovare
il segreto delle cose e, al pari della sua eroina Psiche, si abbandonava
a tutti i dèmoni della curiosità, avventurandosi fino alle
frontiere del sacrilegio. La strada del ritorno dalla Grecia all’Africa,
lo condusse in Egitto ad Oea (odierna Tripoli), dove incontrò Scizio
Ponziano, un antico compagno di studi di Atene, che lo convinse a sposare
sua madre, Pudentilla, la quale, rimasta vedova, desiderava riprendere
marito. Si sposarono e i parenti della donna, adirati nel vedere compromessa
l’eredità, portarono in giudizio il filosofo accusandolo
di aver plagiato e sedotto la donna con arti magiche per impossessarsi
dei suoi averi, e lo accusarono al governatore della provincia (una legge
dell’81 a.C. prevedeva infatti la pena di morte per chi praticasse
la magia). Per difendersi compose un’arringa scintillante di spirito
che ci è conservata con il titolo di “Apologia”. Dopo
il processo, lo scrittore tornò a Cartagine, dove ottenne varie
dignità e dove proseguì la sua brillante carriera di conferenziere.
Infine, la sua morte va collocata probabilmente dopo il 170 d.C. dal momento
che da quest’anno in poi non abbiamo più notizie sul suo
conto.  Apuleio
descrive nelle “Metamorfosi”le vicende di Lucio che trova
diverse stesure in numerosi autori latini: si ritiene che la versione
di Apuleio sia un adattamento di un poeta Bizantino, Lucio di Patre. Nelle
“Metamorfosi” così come nel “Satyricon”,
lo stile viene adattato in base alla materia narrata: ogni singolo personaggio
presenta un proprio codice, una propria peculiarità, delle mezze
tinte. Lucio, il protagonista prova qualsiasi tipo d’esperienza
perché spinto dalla curiositas. Egli spinto dalla curiosità
di sperimentare le arti magiche, finisce per trasformarsi in asino. Presenta,
come ogni uomo, dei limiti: infatti dopo la sua trasformazione, per opera
di una giovane servetta, il ritorno ad essere umano è solo possibile
grazie all’intervento della Dea Iside. Si ha quindi una riappacificazione
con gli Dei, ma allo stesso tempo un’unione con l’intera natura,
l’unico elemento che può portare alla conoscenza dell’intero
universo. Lucio si è macchiato di bassa sensualità e di
una sacrilega curiosità che hanno reso la sua condizione sempre
più miserevole, fino a toccare il fondo. Alla caduta segue l’espiazione
in un corpo animalesco ed in fine il riscatto dell’anima, come prevedevano
le religioni orientali. Lucio affronta diverse situazioni: proprio da
queste Lucio cerca di imparare per compiere un progresso, una trasformazione.
Apuleio
descrive nelle “Metamorfosi”le vicende di Lucio che trova
diverse stesure in numerosi autori latini: si ritiene che la versione
di Apuleio sia un adattamento di un poeta Bizantino, Lucio di Patre. Nelle
“Metamorfosi” così come nel “Satyricon”,
lo stile viene adattato in base alla materia narrata: ogni singolo personaggio
presenta un proprio codice, una propria peculiarità, delle mezze
tinte. Lucio, il protagonista prova qualsiasi tipo d’esperienza
perché spinto dalla curiositas. Egli spinto dalla curiosità
di sperimentare le arti magiche, finisce per trasformarsi in asino. Presenta,
come ogni uomo, dei limiti: infatti dopo la sua trasformazione, per opera
di una giovane servetta, il ritorno ad essere umano è solo possibile
grazie all’intervento della Dea Iside. Si ha quindi una riappacificazione
con gli Dei, ma allo stesso tempo un’unione con l’intera natura,
l’unico elemento che può portare alla conoscenza dell’intero
universo. Lucio si è macchiato di bassa sensualità e di
una sacrilega curiosità che hanno reso la sua condizione sempre
più miserevole, fino a toccare il fondo. Alla caduta segue l’espiazione
in un corpo animalesco ed in fine il riscatto dell’anima, come prevedevano
le religioni orientali. Lucio affronta diverse situazioni: proprio da
queste Lucio cerca di imparare per compiere un progresso, una trasformazione.